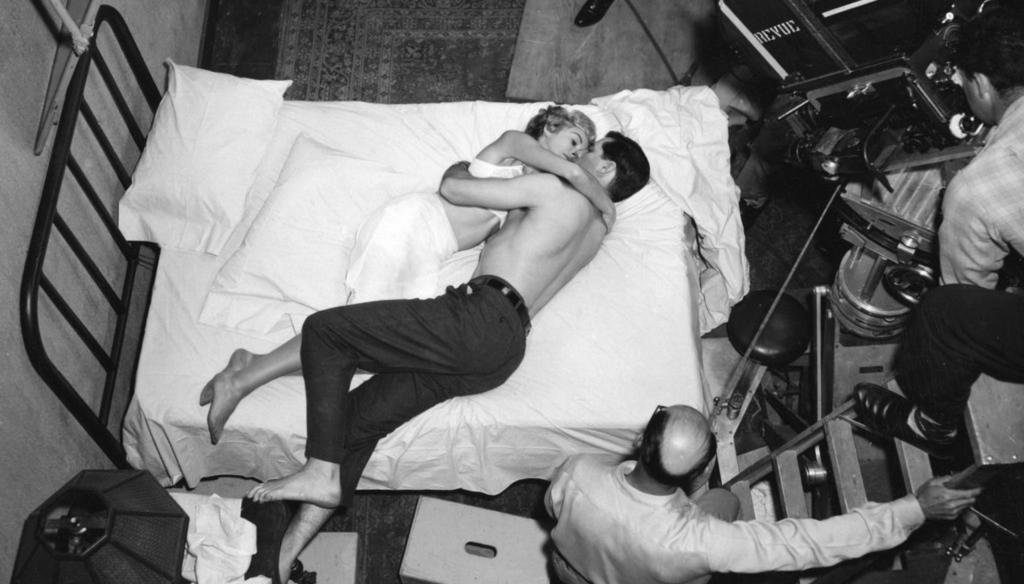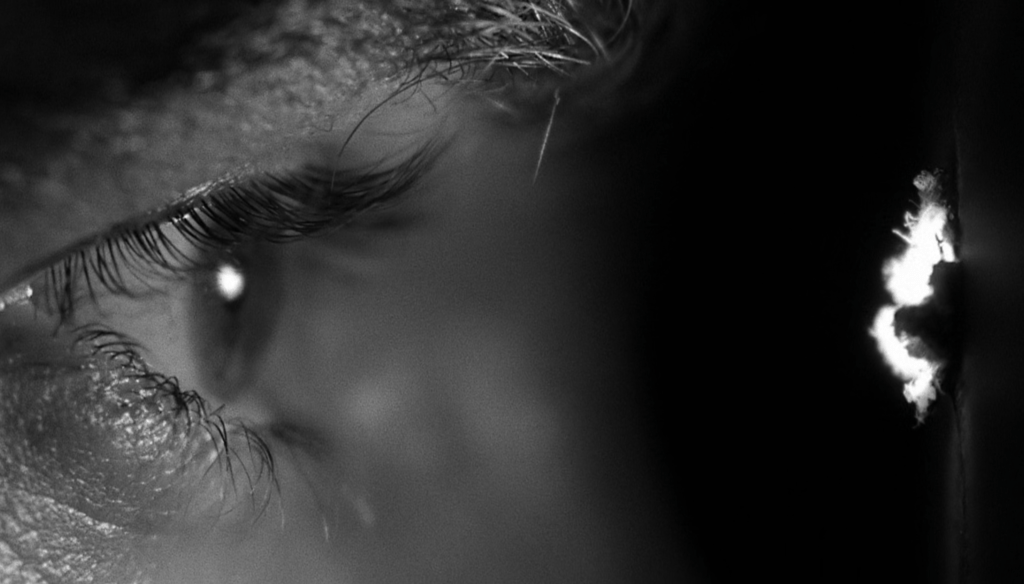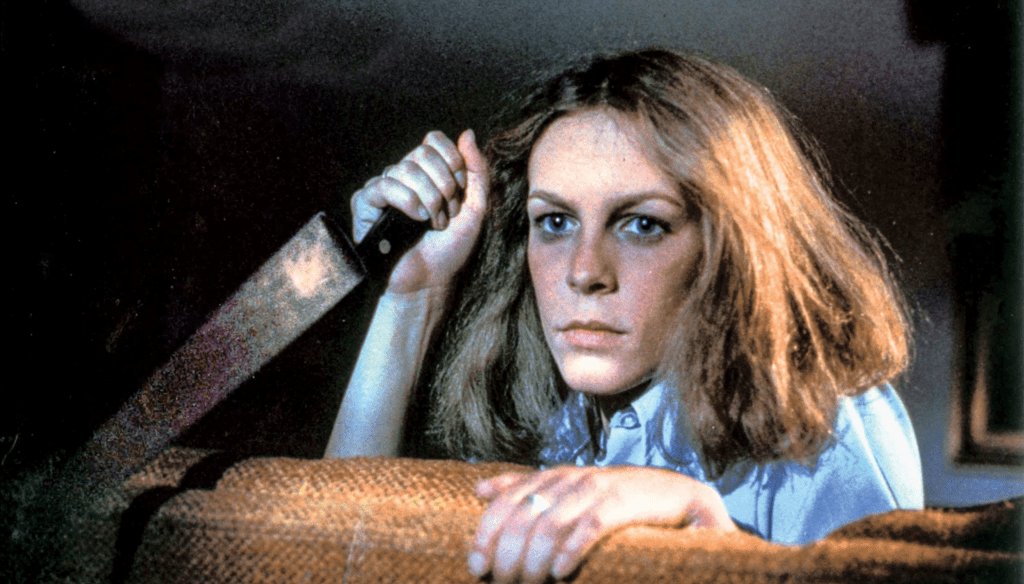The Blues Brothers (1980) di John Landis è uno dei più grandi cult degli Anni Ottanta, un misto fra road movie, commedia nera e musical, sempre al limite fra il surreale e il camp più spinto.
Con un budget di 27,5 milioni di dollari – circa 100 oggi – incassò piuttosto bene: 115 milioni in tutto il mondo (circa 425 oggi).
Di cosa parla The Blues Brothers?
Elwood accoglie Jake, il fratello appena uscito di prigione, con cui si imbarca in un’improbabile quanto fondamentale missione per conto di Dio…
Vi lascio il trailer per farvi un’idea:
Vale la pena di vedere The Blues Brothers?

Assolutamente sì.
The Blues Brothers, insieme a Prendi i soldi e scappa (1969), è fra i titoli che mi hanno formato al cinema, quindi sono molto di parte. Tuttavia, posso dire con serenità che, se questa pellicola è un cult, non è un caso.
Questo incontro così irriverente fra la commedia più improbabile e il disaster movie, con inseguimenti in auto che violano ogni legge della fisica – e non solo – e con performance musicali di alcuni dei più grandi artisti del tempo, sono tutti elementi che rendono questo film una visione davvero imperdibile.
Insomma, cosa state aspettando?

Un uomo di nulla

La lunga sequenza iniziale ci presenta immediatamente Jake senza mostrandocelo in volto.
Ma non serve.
Quando il protagonista riacquista i suoi averi nell’iconica scena dell’inventario, in pochi minuti abbiamo un quadro completo della sua personalità: un uomo legato strettamente a pochi elementi distintivi (il completo e gli occhiali neri), una vita sessuale piuttosto disordinata (i due preservativi) e con pochissimi soldi in tasca (appena 23 dollari e 50).
E il fatto che firmi con decisione con una semplice X, oltre ad essere un momento irresistibilmente comico, racconta perfettamente il totale menefreghismo del suo personaggio.
Ritrovare la via

Nonostante i due fratelli sembrino l’uno la copia dell’altro, in realtà mostrano tendenze opposte.
Come Jake vorrebbe ritornare alla sua vecchia vita, Elwood cerca di farlo reintegrare all’interno di un panorama assai mutato: la Blues Mobile è stata venduta – per un microfono! – la banda si è sciolta ed è ora di tornare alle proprie radici.
La sequenza della suora è una delle più iconiche dell’intero film, dove Landis comincia ad inserire degli elementi quasi fantastici, raccontando una donna così tanto devota a Dio che ne assume anche l’onnipotenza.

Già in questa irresistibile sequenza i due cominciano a capire che qualcosa deve cambiare: è ora di ritrovare la propria spiritualità.
Ma, invece che con delle dovute preghiere, l’epifania arriva da Dio stesso, che illumina Jake nella chiesa Triple Rock e gli fa capire che il suo destino è rimettere insieme la banda e salvare l’orfanotrofio.
Ma è una missione ben più difficile da quello che sembri.
Siamo in missione per conto di Dio!

L’ironia di fondo di The Blues Brothers risiede nel travolgente contrasto fra la missione per conto di Dio e i metodi con cui la stessa viene portata avanti.
Paradossalmente l’illuminazione divina è utilizzata ben poco come motivazione per convincere gli altri membri della banda a tornare a suonare insieme, mentre il metodo più gettonato è l’esplicito ricatto, in particolare nell’esilarante scena del ristorante.
Ma al contempo i due fratelli rappresentano un sogno lontano e apparentemente irraggiungibile, del rimettere insieme una squinternata jazz band e così godere di una vita veramente piena e soddisfacente, pur vissuta alla giornata.

Queste motivazioni sono utilizzate sia per convincere i membri di Murph and Magic Tones, ridotti a cantare canzoncine popolari in squallidi locali, sia, soprattutto, per persuadere Murphy, che ha ormai abbandonato la sua carriera musicale per gestire la tavola calda con la moglie.
Il numero musicale di Aretha Franklin è un unicum all’interno della pellicola, perché rappresenta il momento più strettamente da musical: a differenza degli altri numeri musicali, che sono effettivamente degli spettacoli in cui i personaggi sanno di cantare, in questo caso la donna sta facendo la ramanzina al marito, ma cantando.
Vivere alla giornata

Pur rimettendo insieme la banda, trovare un incarico è tutto tranne che semplice.
Infatti, il primo lavoro è totalmente improvvisato e basato su un incredibile colpo di fortuna: trovandosi per caso vicino ad un locale che effettivamente aspettava una banda di musicisti – in ritardo – i Blues Brothers riescono a rubargli il lavoro.
Questa sequenza racconta la grande capacità di adattarsi e di cavarsela dei protagonisti: pur con una falsa partenza, la band riesce a convincere un pubblico molto ostile, suonando pezzi che soddisfino anche i loro palati così lontani dalla musica jazz e blues.
Ma ovviamente questa piccola vittoria si rivela in realtà un’inevitabile sconfitta, dovuta proprio all’ingenuità dei due protagonisti, che sono ancora costretti a filarsela, facendosi nuovi nemici lungo la strada…
Il punto di svolta

Il punto di svolta per i Blues Brothers avviene, come sempre, grazie al ricatto.
Riuscendo a mettere alle strette Maury Sline e ad ottenere lo spettacolo nella migliore sala del Palace Hotel, i due riescono a creare grande curiosità intorno al loro show, con un marketing piuttosto insistente e sfrontato, ma, in definitiva, vincente.
Ma la schiera di nemici che si è affollata lungo la strada crea non pochi ostacoli alla coppia, che comunque riesce a salvarsi ancora una volta con diversi e abili sotterfugi, mentre Curtis prepara il pubblico al loro grande debutto.
Ma è di nuovo ora di scappare.
Il vero nemico

Il vero villain di The Blues Brothers è la misteriosa donna che tenta continuamente di attentare alla loro vita.
La bellezza del personaggio di Carrie Fisher, al tempo già iconica per Una nuova speranza (1977), sta proprio nel contrasto fra la sua spietatezza, che la porta a distruggere palazzi e far saltare in aria cabine telefoniche, e la totale indifferenza delle vittime dei suoi attacchi.
In questo modo Landis crea un irresistibile interesse per il suo personaggio e per la sua misteriosa storia, che raggiunge il suo picco nell’indimenticabile confronto con Jake nel tunnel, in cui John Belushi regala la migliore interpretazione di tutta la pellicola.
Ma è solo uno dei tanti ostacoli.
I nemici lungo la strada

Personalmente non sono una grande amante degli inseguimenti in auto, anzi spesso finisco per annoiarmi.
Ma le fughe dei Blues Brothers sono forse la mia parte preferita del film.
Già all’inizio l’iconica scena del centro commerciale, in cui i due travolgono con assoluta tranquillità e piacere negozi, oggetti e persone, ma anche i diversi momenti successivi che punteggiano il secondo atto, con incidenti e distruzioni sempre più improbabili.
L’escalation della violenza e dell’intervento di forze di polizia sempre più massicce va di pari passo con l’incredibile capacità dei due fratelli di salvarsi da ogni situazione, arrivando al punto di far fare un salto carpiato alla loro macchina e così sconfiggere i Nazisti dell’Illinois, ritornando in carreggiata totalmente illesi.
The Blues Brothers inseguimento

Tuttavia, non manca una certa amarezza.
All’interno di questa apparente invincibilità dal forte sapore comico, proprio davanti al Richard J. Daley Center di Chicago, i Blues Brothers vedono l’inizio della loro sconfitta: la macchina si distrugge davanti a loro sguardi ammutoliti.
Ma la protezione di Dio gli permette di arrivare illesi fino al 102° piano, riuscendo a consegnare i soldi per salvare l’orfanotrofio. Tuttavia, ormai la grazia divina è finita: neanche il tempo di prendere la ricevuta, e i due sono in manette con centinaia di armi puntate addosso.
Il finale è comunque positivo: persino in prigione, i Blues Brothers riescono a rianimare le folle e a tenere insieme la banda.