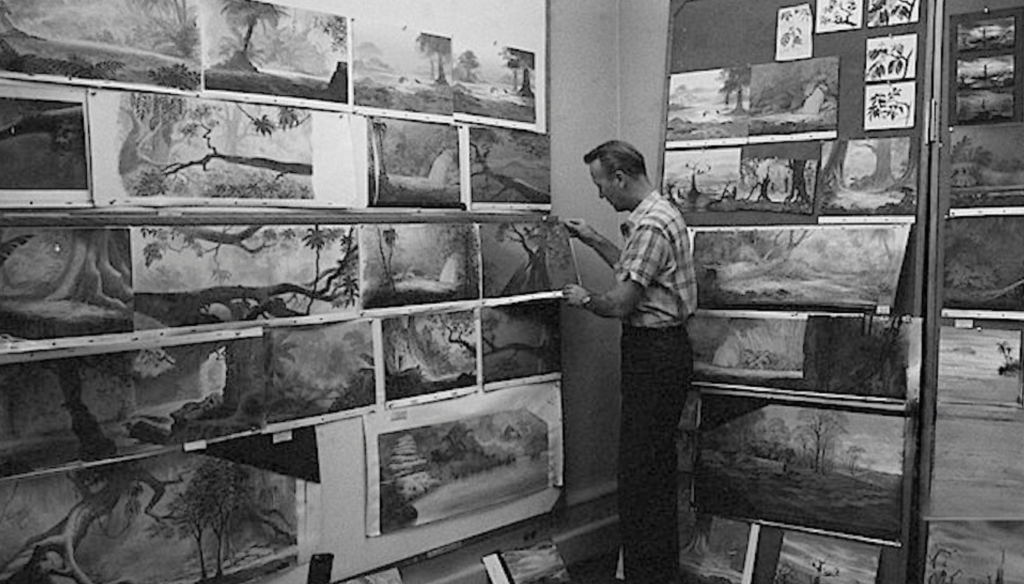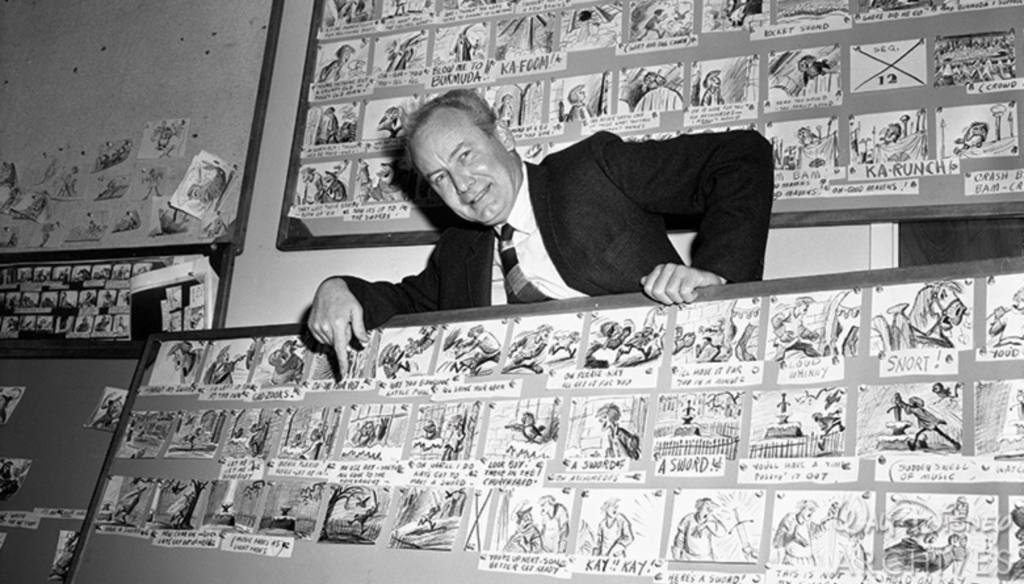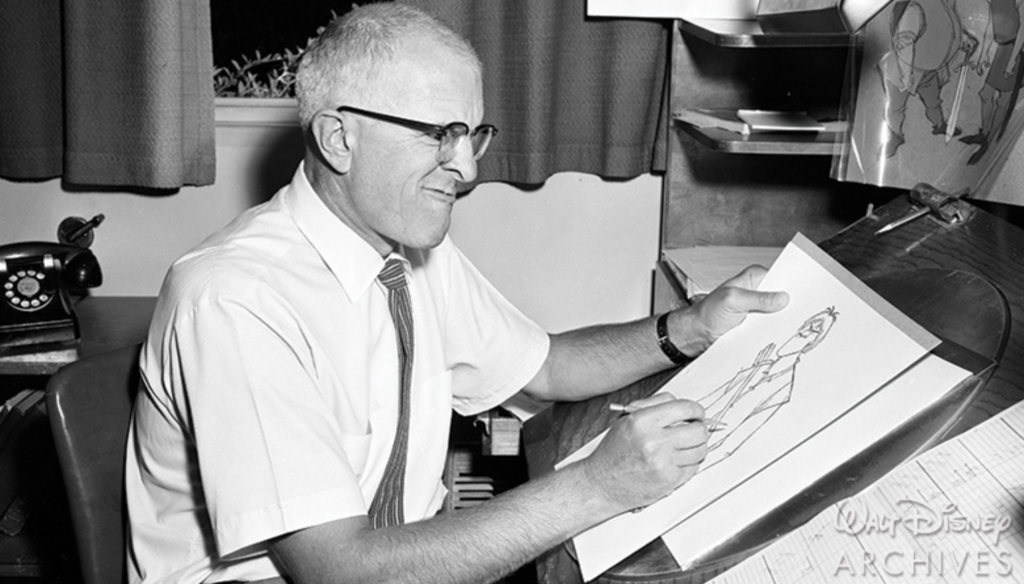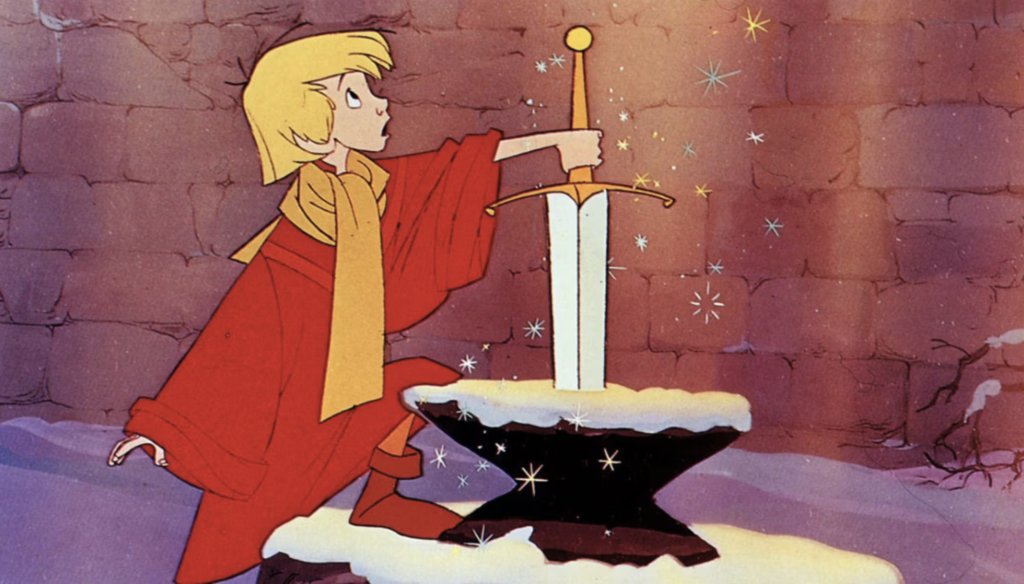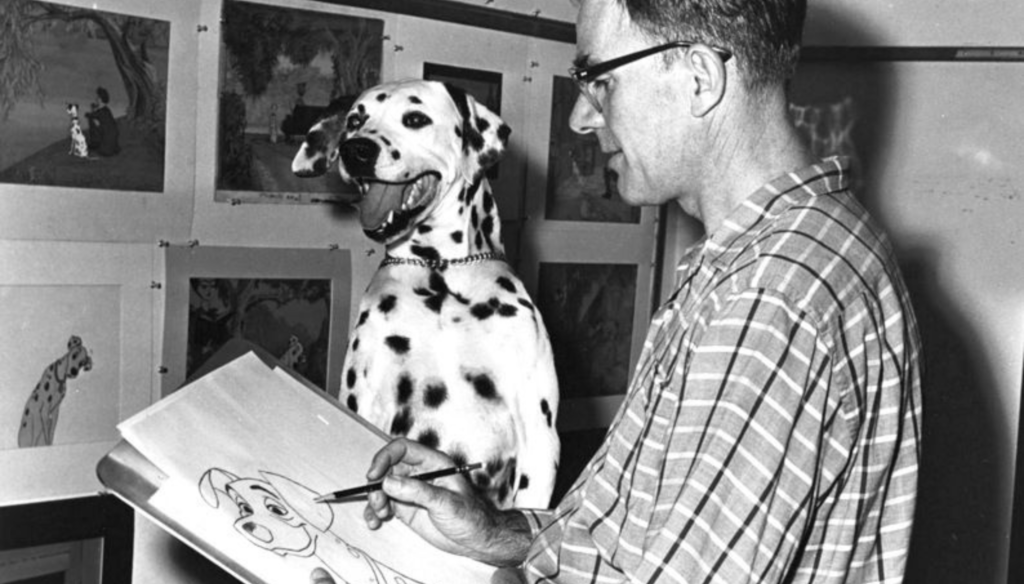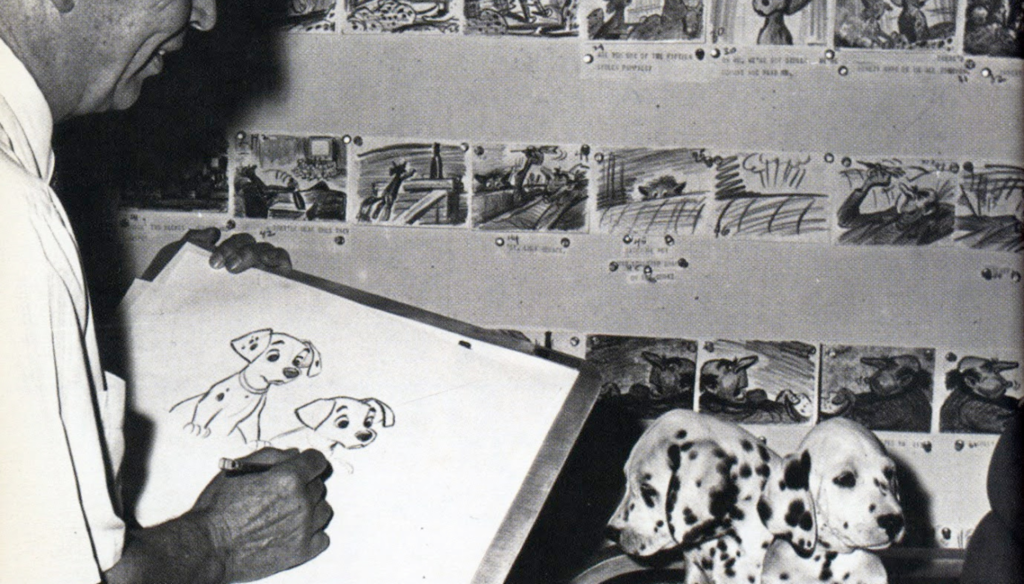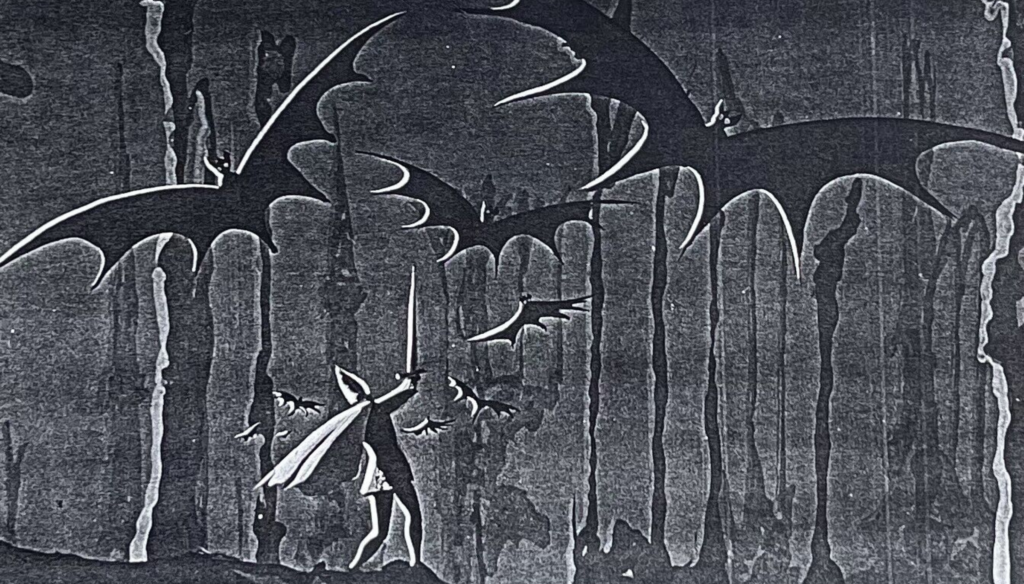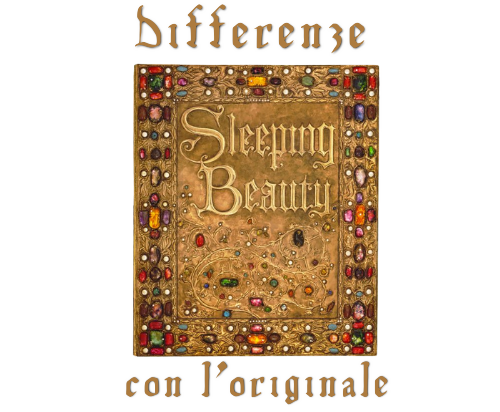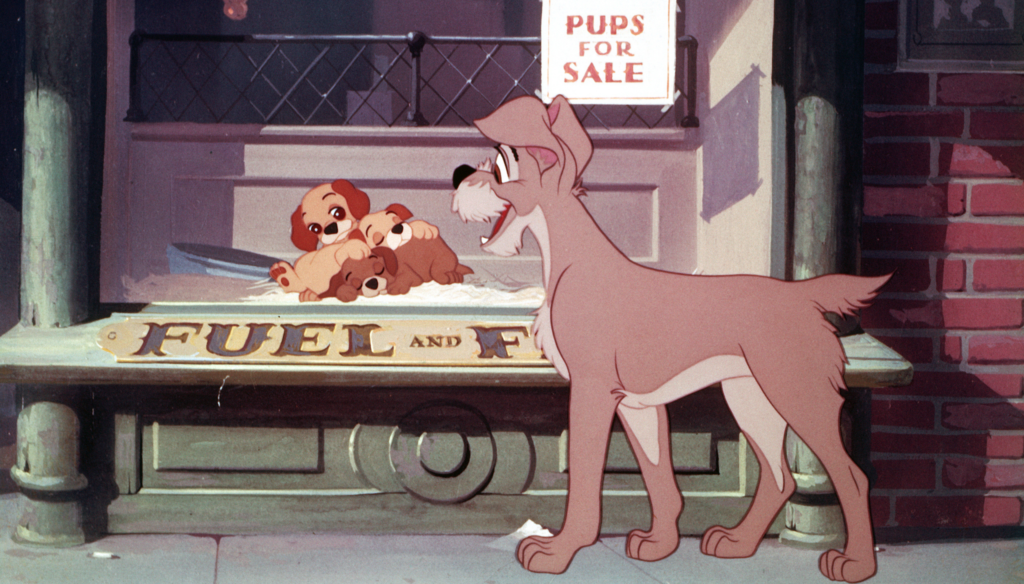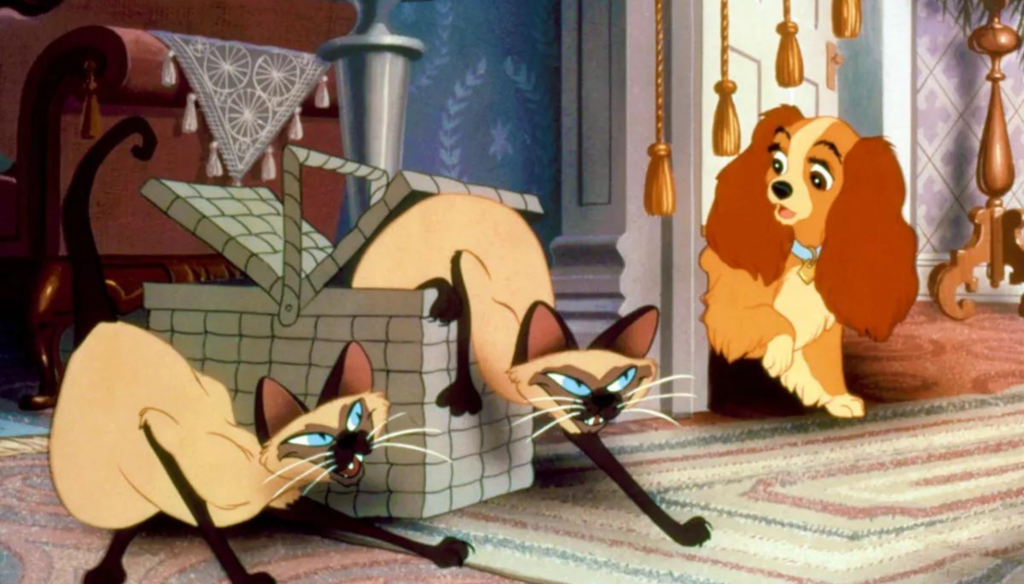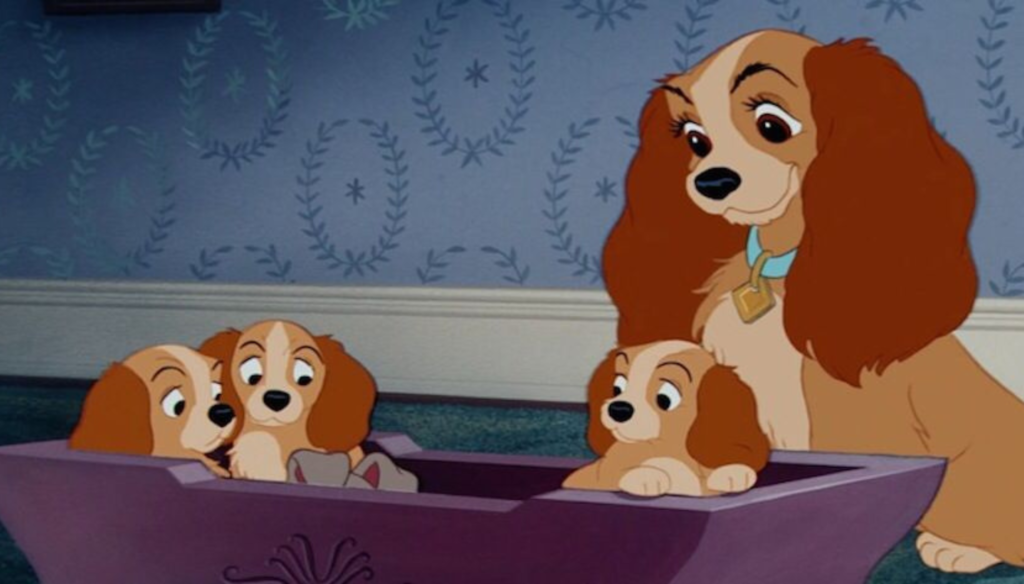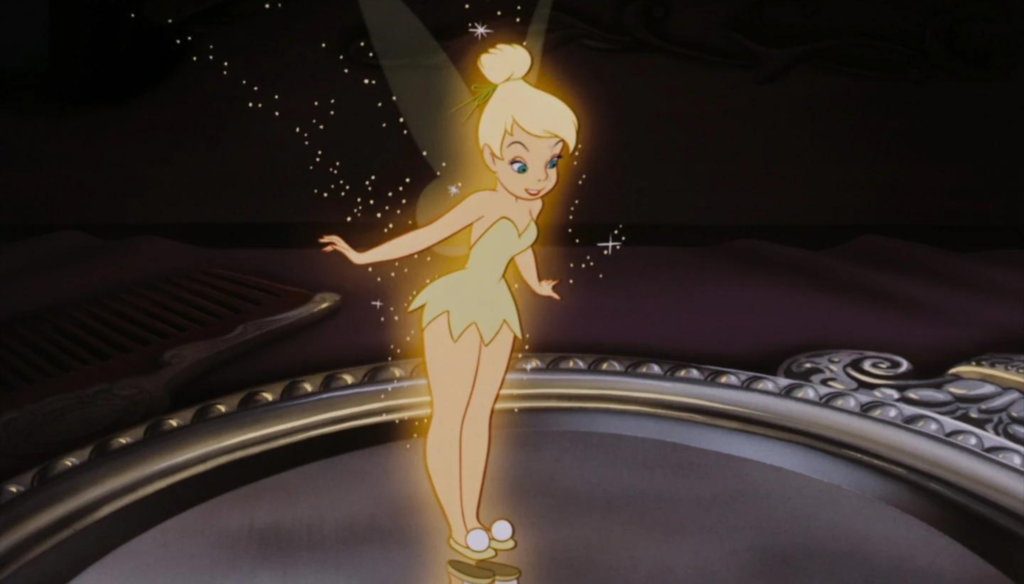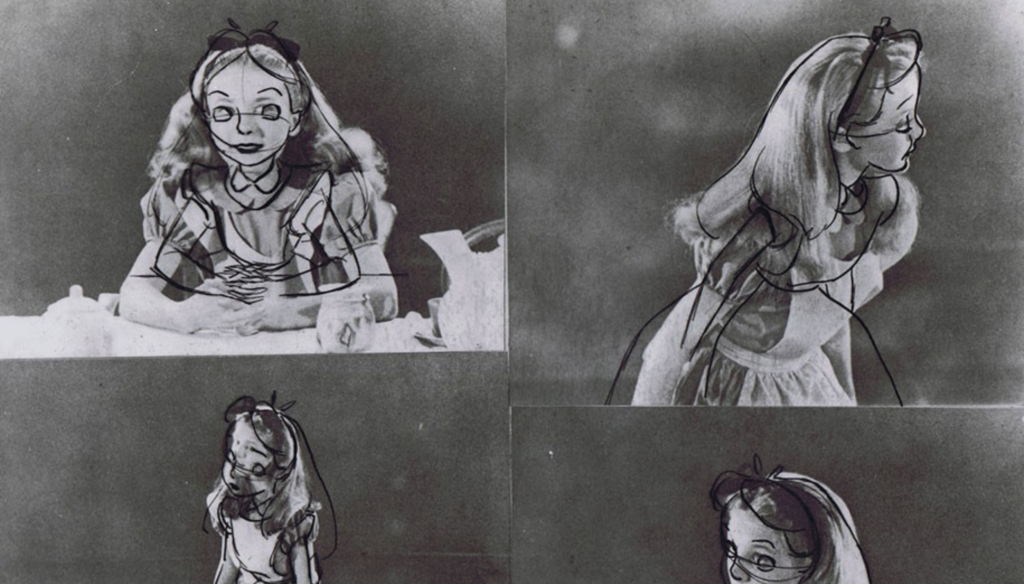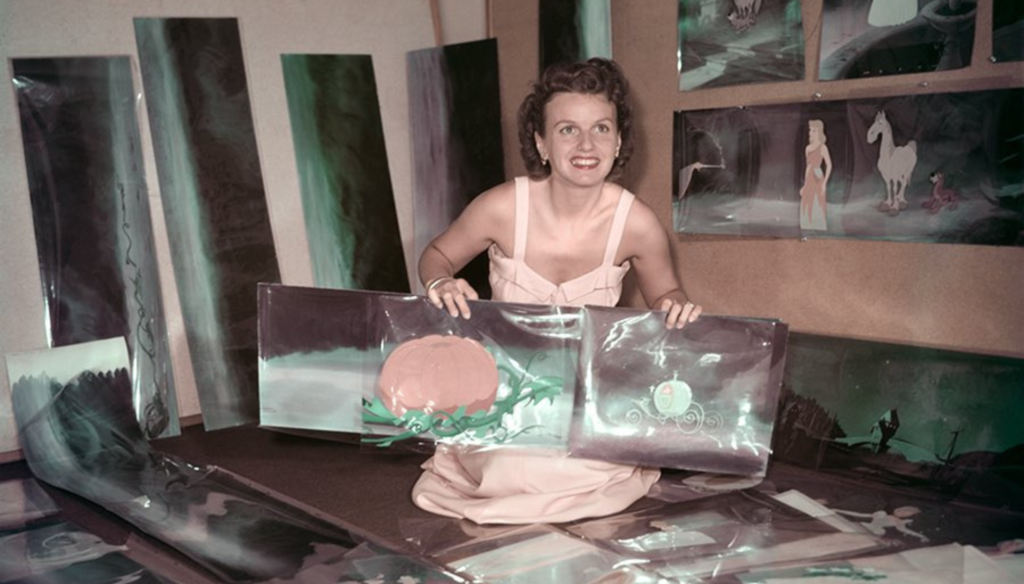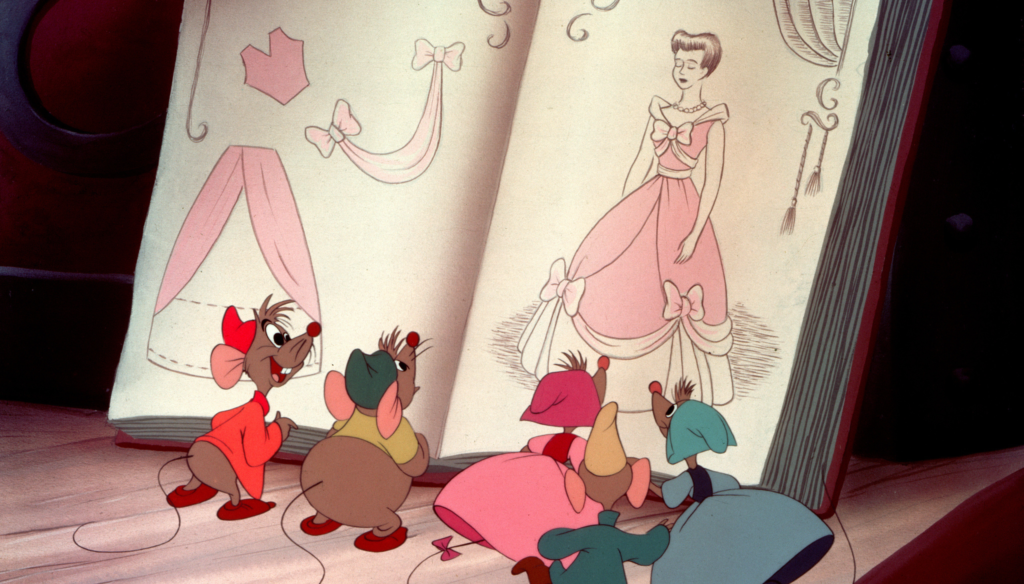Inside out (2015) di Pete Docter è uno dei film Pixar che negli anni sono più entrati nei cuori degli spettatori.
Non a caso, alla sua uscita, con un budget di 175 milioni di dollari, incassò quasi 900 milioni in tutti il mondo.
Di cosa parla Inside out?
Riley è una ragazzina di 11 anni con una vita molto felice. Eppure qualcosa di strano sta succedendo nella sua testa…
Vi lascio il trailer per farvi un’idea:
Vale la pena di vedere Inside out?

Assolutamente sì.
Inside out è uno dei migliori prodotti Pixar usciti dopo la piccola parentesi di produzioni meno indovinate fra il 2011 e il 2013, tornando ai grandi fasti dei primi, indimenticabili film, portando in scena un piccolo cult molto popolare ancora oggi.
E, soprattutto, la pellicola riesce nell’equilibrare la narrazione per renderla accessibile ad un pubblico infantile – in particolare, con i vari accenni comici – ma ampliando la platea per raccontare una storia incredibilmente trasversale.

Origine

All’inizio c’era solo Gioia.
Il suo personaggio rappresenta l’emozione dominante fin dall’inizio della storia, che combatte e tiene a bada gli altri sentimenti, che appaiono per lo più negativi ed incontrollabili – e che, per questo, necessitano di una guida che sappia mettere un freno ai loro slanci.
In particolare, Tristezza viene costantemente messa da parte, considerata un’influenza unicamente negativa che deve il più possibile essere tenuta fuori dal bilancio giornaliero di Riley e dalla sua vita idilliaca.
Eppure, proprio qui sta il problema.

La ragazzina ha una personalità piacevole e frizzante, derivata dai suoi Ricordi Base, esclusivamente gioiosi, e non ha sostanzialmente nulla di cui lamentarsi: una famiglia accogliente e supportiva, amicizie fraterne e solide, una vita sostanzialmente felice…
…che in un attimo viene stravolta da un brusco cambio di scenario, in cui Riley tenta con tutte le sue forze di vedere il lato positivo, ma che, fra il dormire in una stanza spoglia, la pizza con gli odiati broccoli e l’ansia per la nuova scuola, sembra davvero impossibile.
Ma Riley è costretta ad essere felice.
Deriva

Quando Gioia sembra ormai costretta a farsi da parte in una giornata disastrosa, la madre interviene in un modo apparentemente molto positivo, in realtà assolutamente disastroso per il benessere emotivo della protagonista:
si congratula con lei per riuscire ad essere felice, nonostante tutto.
Così Riley si trova sostanzialmente costretta a nascondere le sue vere e complesse emozioni, e, appena messa al centro dell’attenzione con una delle sue più grandi paure – essere chiamata dalla maestra – crolla totalmente su sé stessa.

Infatti, anche se Tristezza è stata programmaticamente messa da parte, non riesce a trattenersi dall’intrufolarsi in questa delicata situazione, andando ad inquinare quei ricordi felici che hanno definito la personalità di Riley fino a questo momento…
…e a creare così un ricordo fondamentale del tutto infelice.
Ma questo è solo l’inizio di una grande e fondamentale avventura.
Percorso

Il viaggio di Tristezza e Gioia funziona in due direzioni.
Da una parte, mostra l’intricato quanto spesso divertente dietro le quinte della testa di Riley, che ricorda in qualche modo i fasti di Esplorando il corpo umano (1987 – 88) in cui la mente della protagonista è una piccola fabbrica con le sue diverse sezioni e regole.
Dall’altra, racconta ancora più esplicitamente il rapporto fra le due emozioni, in condizione di totale antagonismo, dovuto anche ad una sostanziale superficialità di Gioia, che ha sempre considerato in maniera esclusivamente negativa Tristezza.
E proprio per questa non la ascolta.

Infatti, Gioia si intestardisce verso una conclusione dell’avventura semplice e positiva, non riuscendo ad accettare il crollare progressivo dei capisaldi della personalità di Riley – in particolare, la famiglia – e rimanendo sostanzialmente indifferente ai consigli di Tristezza.
Una tendenza che si nota molto chiaramente quando, nonostante gli avvertimenti della sua compagna di viaggio, Gioia sceglie di seguire Bing Bong nella sua disastrosa scorciatoia, e così anche quando si intestardisce che l’unico modo per svegliare Riley sia con immagini gioiose e assurde, invece che con la più semplice paura.
In senso più generale, Gioia non capisce l’oblio.
Oblio

La memoria è fondamentale quanto l’oblio.
Vivendo in un momento di passaggio, è del tutto normale per Riley dimenticarsi di alcuni ricordi inutili – come nozioni puramente scolastiche – o lasciarsi alle spalle elementi fin troppo legati alla sfera infantile – come il castello delle principesse…
…o lo stesso Bing Bong.

L’amico immaginario di Riley è privilegiato da Gioia perché legato ad una fase della vita della ragazzina più semplice ed immediata, definita da emozioni chiare e divise a compartimenti stagni.
E, soprattutto, Bing Bong è legato ad emozioni del tutto positive.
E proprio Bing Bong è una delle vittime dell’autodistruzione disastrosa – quando necessaria – dei capisaldi della sua personalità di Riley, ormai in balia di istinti immediati ed emozioni esplosive ed incontrollabili.
Insomma, per Riley è ora di crescere.
Crescere

La crescita è equilibrio e varietà.
Possiamo notare che la mente della madre di Riley l’emozione di punta sia la Tristezza, nonostante la donna si dimostri in più momenti propositiva ed accogliente, per nulla quindi dominata da un unico sentimento, ma capace di mantenere solido un equilibrio emotivo fondamentale per l’essere adulti.
Proprio per questo Gioia, che in un primo momento aveva cercato di mettere da parte Tristezza, capisce come questo sentimento sia in realtà presente anche nei momenti che pensava fossero esclusivamente felici, e come sia anzi necessario per plasmare la personalità della protagonista.

Per questo infine Riley si sente rinata, torna dalla sua famiglia e accetta finalmente che i suoi ricordi positivi le trasmettano invece una forte malinconia, capendo al contempo come gli stessi possano essere anche l’occasione per ripartire come una persona diversa e più consapevole.
Così la sua mente è ora aperta a nuove reazioni ed emozioni, a ricordi non più definiti da un unico sentimento, ma resi significativi perché nati dall’unione di più di questi, sia positivi che negativi, per definire una nuova, variegata personalità.
E ora manca solo la pubertà.