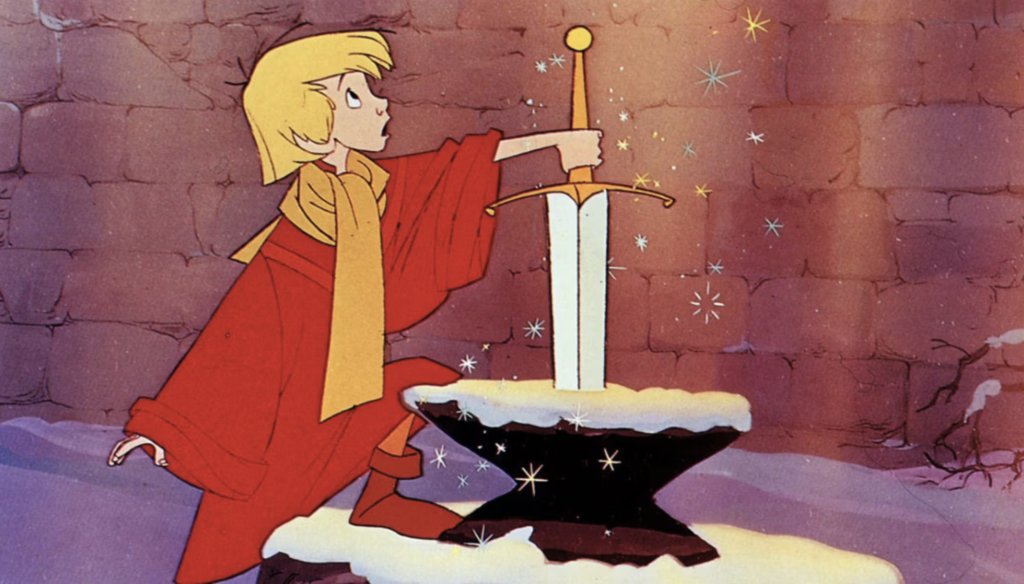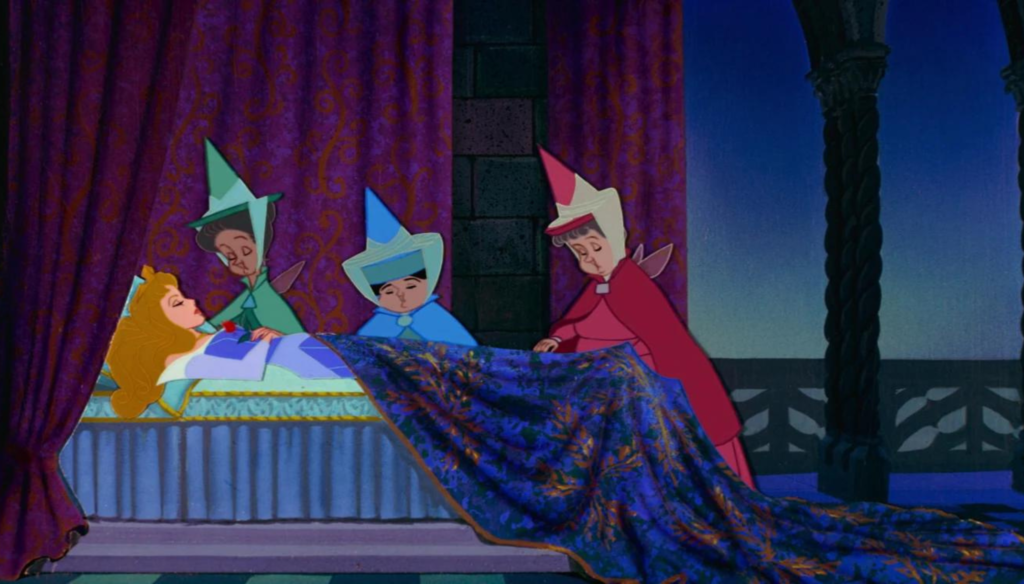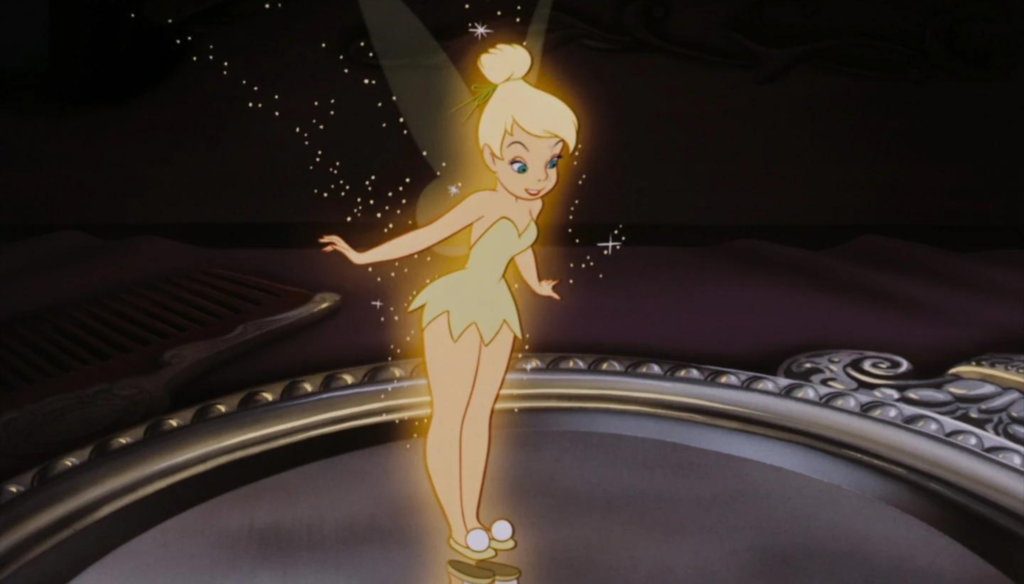Inside out 2 (2024) di Kelsey Mann è il sequel dell’omonimo film Pixar del 2015.
A fronte di un budget di 200 milioni di dollari, ha aperto benissimo al primo weekend americano: 155 milioni di dollari, prospettandosi uno dei maggiori incassi dell’anno.
Di cosa parla Inside out?
Riley ha finalmente tredici anni ed è pronta ad una nuova sfida: l’adolescenza.
Vi lascio il trailer per farvi un’idea:
Vale la pena di vedere Inside out 2?

Assolutamente sì.
Inside out 2 è probabilmente uno dei prodotti Pixar meglio riusciti dell’ultimo periodo, riprendendo lo scheletro narrativo del primo capitolo e ampliando la storia in un’esplorazione mai banale dell’adolescenza e di tutti i suoi profondi drammi.
L’unico elemento che non mi ha convinto del tutto è proprio questo senso di more of the same: la storia è molto simile a quella del precedente film, quantomeno nelle dinamiche, anche se poi si arricchisce di un impianto comico ben più travolgente e indovinato.
Ma, dopo quasi dieci anni di attesa, se lo può anche permettere.

Stabilità

All’inizio di Inside out 2 troviamo una Riley diversa.
Dopo aver superato il primo, comprensibile shock del cambiamento, la protagonista è riuscita gradualmente a costruirsi una nuova vita ed una nuova personalità, proprio ad un passo dal complesso passaggio alla pubertà.
Ma, anche in questi caso, Gioia ricade sempre nello stesso errore.

Nonostante la pellicola non si dimostri per nulla dimentica del suo passato – Gioia effettivamente include tutte le emozioni – l’emozione protagonista si impegna comunque nel cercare di scremare i diversi ricordi, per mantenere solamente quelli positivi, utili per creare la Riley perfetta.
In questo senso piuttosto interessante l’introduzione dei capisaldi della personalità della ragazzina protagonista, costruiti sulla base dei ricordi e delle esperienze più costruttive che fanno sbocciare una Riley che vive della consapevolezza di essere una persona buona.
E basta.
E proprio qui sta il punto.
Shock

Lo shock della pubertà sembra ingestibile.
Riley diventa emotivamente intoccabile, ogni emozione, che prima veniva vissuta in maniera ragionevole, sfocia in un’alternanza di sentimenti esplosivi ed incontrollabili, in cui Riley passa dall’essere furiosa a sentirsi impossibilitata a continuare a vivere…

Così, anche le sue emozioni si evolvono: davanti all’ulteriore minaccia di cambiamento della vita della protagonista, Riley comincia ad ossessionarsi tramite Disgusto per i fantasmi di un tradimento all’orizzonte, ricadendo nella totale disperazione.
E, infatti, è ora di dare spazio a nuove emozioni.
Emozioni

La rappresentazione di Ansia è perfetta.
Già il character design suggerisce un sentimento di ossessione e di nervosismo – gli occhi che coprono la maggior parte del volto, la pelle tirata, i capelli ritti in testa… – e si completano nell’atteggiamento instabile e nevrotico che prende piano piano sopravvento nella testa di Riley.
Altrettanto azzeccata è Ennui, che, con la sua testa calata di lato e il suo accento francese, non rappresenta semplice la noia, ma bensì una sorta di nichilismo, di disinteresse totale per quello che ci circonda – fra l’altro, rappresentando una perfetta controparte dell’ansia pervasiva.

Inizialmente invece Imbarazzo rimane più sullo sfondo, proprio per una sua inguaribile timidezza e anch’essa, più in generale, non rappresenta solamente l’imbarazzo, ma proprio un senso di inadeguatezza, di non essere nel posto giusto – e per questo di voler sprofondare.
Forse meno incisiva Invidia, una versione quasi più maligna di Disgusto, che durante la pellicola ha un’impronta meno memorabile sulla storia, dovuto anche al suo lavorare continuamente a stretto contatto con Ansia, che la porta alla lunga nel confondersi con la stessa.
Ma questo ora è tutto il mondo di Riley.
Nuova

Ponendosi apparentemente come il villain della storia, Ansia conquista la mente di Riley…
… togliendo di mezzo tutto quello di positivo che c’era prima, per lasciare spazio ad un cambio di passo per creare una Riley nuova di zecca, spietata e egoista, con l’obiettivo – paradossalmente – di farla sentire al sicuro dall’angosciante futuro.

In questo senso Inside out 2 gioca molto bene nel raccontare quanto Riley ingigantisca ogni situazione all’inverosimile…
…finendo per vivere senza più un contatto effettivo con la realtà, ma del tutto calata all’interno di un universo di incubi e di demoni, in una rete di ansie che sembrano minacciare un destino di la solitudine, di isolamento sociale, di disprezzo…
Ma non ci sono solo due Riley.
Consapevolezza

Il punto di arrivo di Riley è il viaggio di Gioia.
Proprio come desidera una Riley perfetta e senza macchia, allo stesso modo anche Gioia sente su se stessa la pressione di perfezione e di risolutezza che si è auto-imposta, che la porta in più momenti a crollare, sopraffatta dalla situazione, soprattutto davanti al continuo confronto con Ansia.
Per questo la soluzione finale per tornare al Quartier Generale è in realtà una spia della sua stessa presa di consapevolezza: dando libero spazio a quei ricordi finora messi da parte, Gioia permette agli stessi di inquinare i capisaldi della personalità di Riley.

E per questo il finale è così importante.
Inside out 2 sceglie di distaccarsi da una narrazione molto semplicistica e tipica per i prodotti dell’infanzia, in cui il punto di arrivo è sempre rappresentato dal raggiungimento di una bontà indispensabile per il protagonista, aderendo ad una visione in bianco e nero della vita e delle relazioni.
Al contrario, questa pellicola ci racconta come sia del tutto normale vivere una via di mezzo.

Possiamo essere altruisti, creativi e intraprendenti, ma al contempo anche egoisti, bisognosi di attenzioni, sfiduciati, ricalcando e ampliando il concetto del cocktail di emozioni già introdotto nel precedente capitolo.
E c’è ancora spazio per crescere.