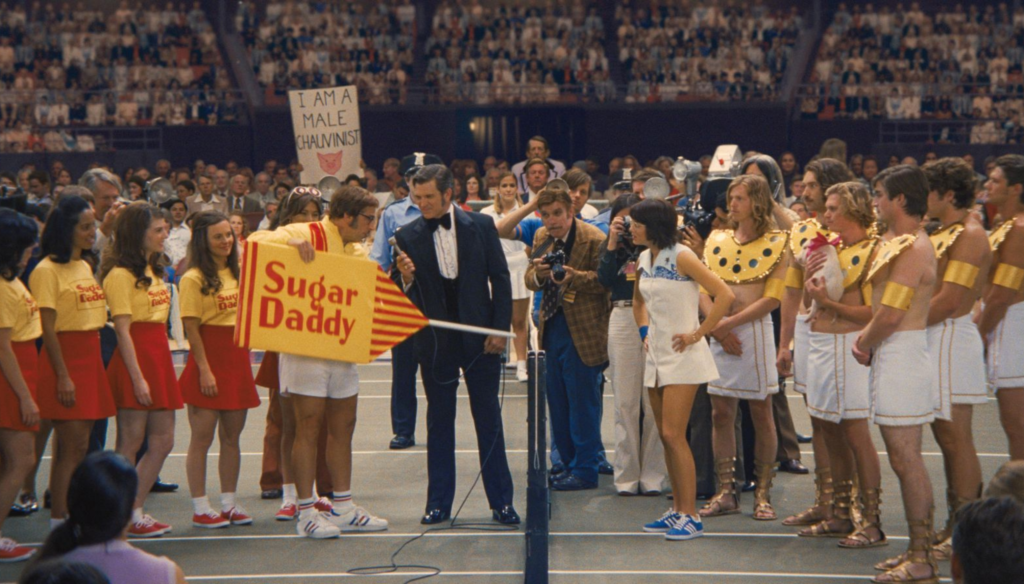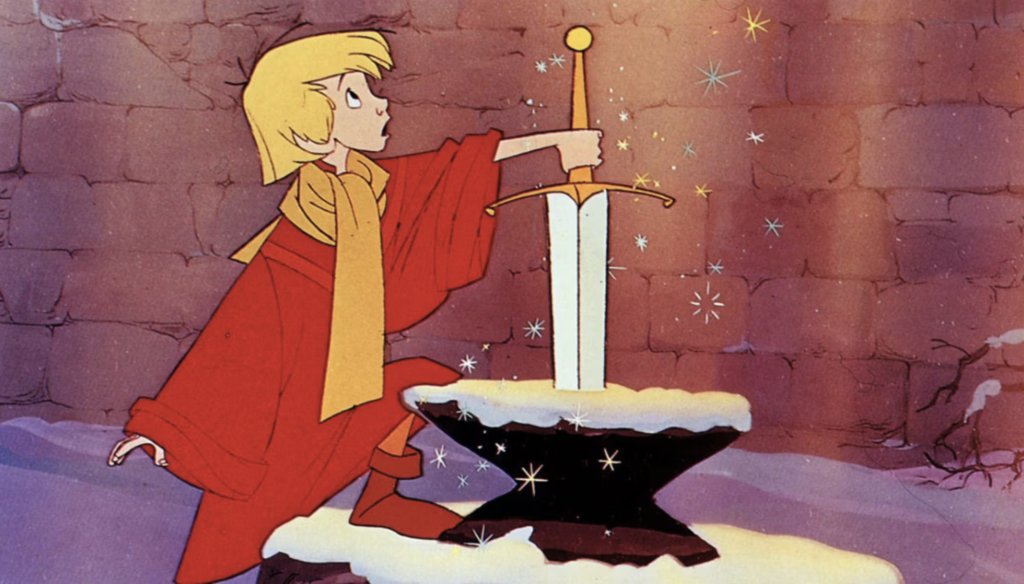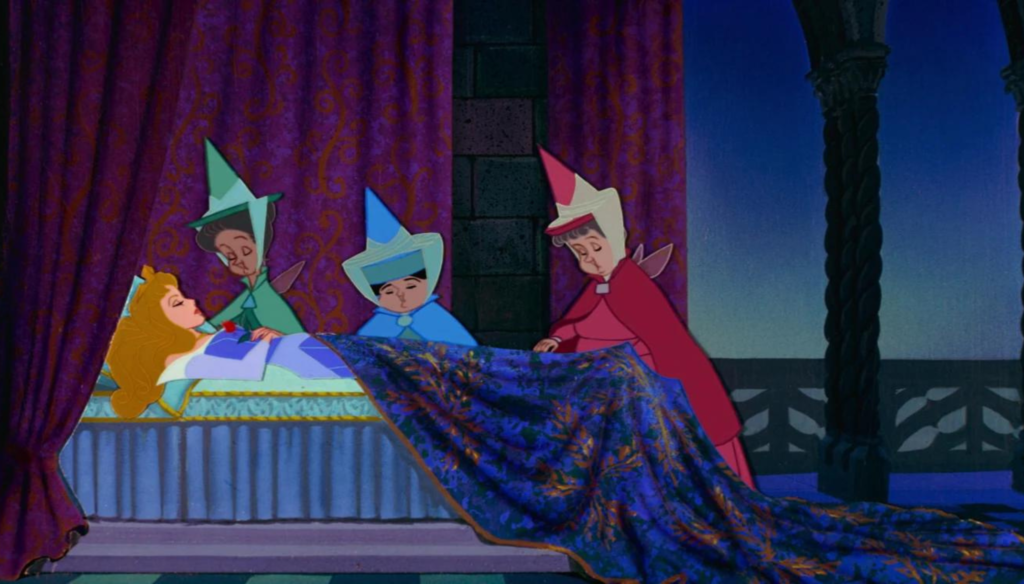Dallas Buyers Club (2013) di Jean-Marc Vallée è un film drammatico basato sulla vera storia di Ron Woodroof.
A fronte di un budget molto piccolo – appena 5 milioni di dollari – è stato un ottimo successo commerciale: 55 milioni di dollari in tutto il mondo.
Di cosa parla Dallas Buyers Club?
Texas, 1985. Ron è un rude texano che vive fra scommesse, dipendenze e sesso occasionale. Ma una visita imprevista in ospedale gli cambierà per sempre la vita…
Vi lascio il trailer per farvi un’idea:
Vale la pena di vedere Dallas Buyers Club?

Assolutamente sì.
Dallas Buyers Club è uno splendido spaccato – per certi versi anche molto attuale – della vergogna sociale che nacque intorno all’HIV e alla comunità queer negli Anni Ottanta, e al contempo anche della poca incisività di un sistema sanitario basato – ancora oggi – su un mero giro di affari.
Fra l’altro, un film tanto più imperdibile per la coppia esplosiva di Matthew McConaughey e Jared Leto: l’uno nel momento di rinascita artistica appena prima di True Detective (2014), l’altro in uno degli ultimi ruoli significativi prima di sporcarsi le mani col cinema di serie B.
Insomma, non ve lo potete perdere.

Origine

Ron è definito dal suo ambiente.
Visto che l’HIV non è altro che un affare dei froci (faggot), né Ron né i suoi degni compari si devono preoccupare nel loro essere coinvolti in un sesso occasionale e disordinato, che si svolge nel dietro le quinte della massima espressione del machismo – il rodeo.
Allo stesso modo, il loro utilizzo di droghe e di siringhe condivise racconta la totale impreparazione degli Stati Uniti davanti alla nuova minaccia sanitaria, incapace di creare la giusta comunicazione che metta in guardia persino le persone non queer dai rischi a cui potevano andare incontro.

Una situazione che determina anche la totale casualità della diagnosi, che avviene per tutt’altro motivo, per un semplice incidente sul lavoro, che però porta i dottori ad alzare qualche dovuto sopracciglio davanti alla stranezza degli esami del protagonista.
E per questo Ron parte da una negazione…consapevole.
Negazione

La negazione di Ron è estremamente violenta.
Del tutto convinto del pensiero comune – l’HIV ce l’hanno solo i ricchioni – il protagonista vive la sua diagnosi sulle prime più come un’accusa alla sua sessualità e al suo stile di vita – anche prevedendo il tipo di esclusione sociale che seguirà…

Così il protagonista si confida con uno dei suoi compari per avere conferma dell’impossibilità della sua diagnosi, sicuramente derivata da un mischiare il suo sangue da vero uomo con quello di qualche esemplare umano di minor valore.
Eppure questa sua confidenza, seguita dalla sua consapevolezza involontaria che lo porta a non voler intrattenersi con le donne quella sera, lo rendono nel giro di una notte un reietto sociale, il protagonista di tutta la tragica vergogna di essere in realtà un omosessuale.
Ma non esiste un’alternativa.
Solo

Ron deve fare da solo.
Dalla Buyers Club racconta perfettamente la situazione ancora molto attuale degli ospedali negli Stati Uniti, in cui un giro di soldi abbastanza importante permette di prendere i vergognosi pazienti dell’HIV e renderli dei topi da laboratorio.
Davanti all’impossibilità della certezza della cura, davanti alla prospettiva di una morte sicura in meno di un mese, Ron comincia a procurarsi sottobanco questo farmaco miracoloso, finendo così solo per intossicarsi e per distruggere più o meno inconsapevolmente il suo corpo.
E, anche in questo caso, la salvezza è del tutto casuale.

Dopo essere nuovamente rimesso su un letto d’ospedale senza nessuna prospettiva di vita, il protagonista sorpassa il confine e comincia ad assumere una nuova, pericolosa consapevolezza grazie ad un altro emarginato: un dottore radiato dall’albo che deve curare in clandestinità.
Fuori dal giro d’affari dell’AZT, questa medicina miracolosa si rivela infatti un killer del sistema immunitario, che agisce molto più alla cieca di quanto dovrebbe – mentre la rinascita di Ron è dovuta a ben altro…
E allora comincia la lotta.
Ombra

La lotta di Ron avviene nell’ombra.
Consapevole dell’impossibilità di vendere quelle medicine che potrebbero davvero salvare delle vite, il protagonista riesce ad agire nelle zone d’ombra, a creare un club farmaceutico in cui si paga solo il costo d’ingresso, e poi si riceve in omaggio le effettive medicine.

Comincia così una lotta senza quartiere, in cui Ron è costantemente vessato dal governo, che gli continua a sfilare da sotto le mani il suo prodotto potenzialmente salvifico, nonché la sua possibilità di portare avanti una ricerca indipendente.
Eppure il protagonista non si arrende mai, non si fa mai veramente sottomettere da un sistema che non è mai stato al suo fianco, ma che anzi ha voluto impedirgli di rivaleggiare con case farmaceutiche ben più ricche e potenti – e quindi le uniche che hanno diritto di parola.
E, per una volta, non è solo.
Alleato

Ron ha al suo fianco degli improbabili alleati.
Da una parte la dottoressa Eve, interpretata da una Jennifer Garner che purtroppo scompare davanti a due attori di così grande talento, ma che porta in scena un personaggio assolutamente necessario per riequilibrare le parti in gioco.
Il suo personaggio infatti assume una graduale consapevolezza al pari di Ron, pur rimanendo per molto tempo instancabilmente legata all’idea che tutto quello che succede al di fuori dell’ospedale è fin troppo pericoloso – nonostante lei stessa mostri dei dubbi fin da subito sul AZT.

Ma, ancora più importante, Ron ha al suo fianco Rayon.
Da buon texano machista, sulle prime il protagonista è sostanzialmente disgustato da questo strambo personaggio, che per lui non è altro che un orribile travestito da cui non vuole neanche lasciarsi toccare…ma che infine sceglie come suo braccio destro.
E il loro rapporto effettivamente si dimostra fino alla fine estremamente ostile, ma sempre meno per l’identità sessuale del personaggio, ma invece per il continuo pungolare dello straordinario Jared Leto – per esempio, quando inquina la parete del porno di Ron con le sue fotografie.
Eppure, la sua morte è fondamentale.
Vittoria

La crescita di Ron è sorprendente.
La sua lotta comincia come una battaglia per la propria salvezza, contro un sistema ingiusto, parallelamente riuscendo anche a lucrarci sopra, e rimanendo ancora per molto tempo insofferente alla presenza di Rayon.
Eppure, durante la pellicola il protagonista cambia profondamente se stesso, evade da quel mondo piccolo e meschino del machismo texano e si avventura nel più fragile ruolo del rivoluzionario…

…persino difensore degli ultimi, che costringe il suo ex-compare a stringere la mano a quel disgustoso travestito, a cui infine si lega al tal punto emotivamente che, quando infine scompare dalla sua vita, il protagonista abbandona persino i sogni di guadagno e lascia entrare chiunque nel suo club.
Forse Ron Woodroof non è riuscito infine a salvarsi, ma è riuscito a combattere per avere quel tanto di vita che gli bastava per minare la credibilità di un governo classista, per vivere una vita dignitosa, morendo da uomo libero – e non ucciso da quello stesso sistema che millantava di salvarlo.